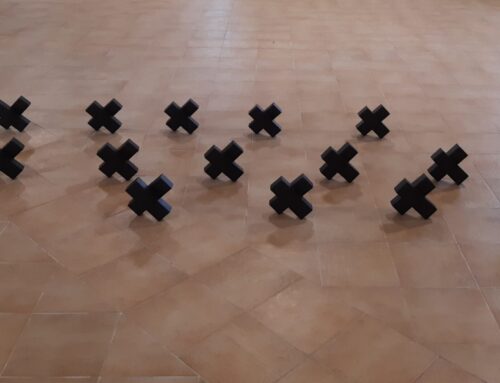Luigi Tallarico – Critico d'arte
Presidente del Centro studi "Futurismo-oggi" e "Storia delle poetiche tra le due guerre – Roma
…Non deve pertanto sorprendere che un artista, nata e vissuta in Calabria e in un particolare tratto di regione da sempre legato ad una tradizione intesa come attaccamento alla terra, la lingua, alla "Gran Madre", secondo la definizione del "calabrese" Boccioni, abbia sentito la necessità di un mutamento delle forme che riteneva inidonee ad interpretare la nuova condizione della vita e dell'arte. E proprio il legame di arte-vita, e del nuovo in quanto vivente, ha portato Maria Credidio alla scelta di un linguaggio che fosse la risultante del concetto rimbaudiano-futurista, sul presupposto che la vita come la storia non procede a salti. Ma soprattutto nella consapevolezza che la scelta di un espressione estetica non può non cogliere le influenze analogiche e memoriali succedute nel tempo, anche se la consecutio temporum dell'arte non consente alle forme una pedissequa dipendenza stilistica. É risaputo che una espressione d'arte è viva, e si rinnova rapidamente, quando la cultura che l'esprime è dinamica e non ristagna nella contemplazione del "già stato" e del "già fatto". Da qui la diversità- continuità dell'arte di Maria Credidio, che mentre si riallaccia ai concetti del dinamismo plastico e della simultaneità, secondo la bipolare interpretazione data da Boccioni e Balla, in effetti interpreta la dislocazione e lo smembramento delle figure e degli oggetti nello spazio in maniera più plastica che dinamica, frenando il ritmo spiralico bocciniano e assorbendo le nuances cromatiche e liriche di Balla. D'altra parte, la pittrice calabrese, che è dotata di un' abilità manuale e di un segno grafico di fattura- e lettura-classica(sono noti i rilievi fisionomici di dive e personaggi in),non solo punta-per l'essenza all'annullamento del fenomenico e del rappresentativo, ma è portata a collocare le forme in uno spazio non più mobile ,ma bloccato e chiuso. Sicchè, mentre i rimandi linguistici avviano un discorso di non poca importanza sugli sviluppi formali delle poetiche dell'astratto – concreto, in effetti non escludono una nuova e diversa interpretazione delle componenti sia plastico- novecentesche che materiche e informali. In effetti l'artista calabrese dopo aver movimentato la forma con angolazioni geometriche, ritmi serrati e simultanei o avere resa la linea flessuosa e scandita in fasce circolari tende a ricomporre l'opera attraverso un colore compatto e isolato nella circolarità delle losanghe, organizzando il quadro non già attraverso le metamorfosi sregolate, bensì mediante una costruttività più razionale. A ben vedere queste forme-cibo prelibato dei critici d'arte se sembrano fatte per incasellare o per limitare la coerenza concettuale e fattuale di un artista, in effetti approfondiscono la varietà e la diversità dei motivi linguistici che, in Maria Credidio, allargano il plesso interpretativo della sua arte in progress .E nel contempo invitano a considerare l'invariante dei suoi momenti espressivi in un analisi che potrà apparire forse didascalica o legata ai ,motivi temporali, ma che meglio si precisa se si collega ai momenti iniziali e successivi di un percorso spirituali, comunque unitario nei suoi elementi contrari .Infatti il riesame del primo m omento ci porta a collegare la scomposizione della figura con lo spazio gremito e che, come prospetto in "Attesa", si presenta con i piani scanditi in un rigido geometrismo. Oltre tutto è evidente nell'opera la presenza del suo doppio rappresentato sia dalla dinamicità delle forme che dalla stasi concettuale, indicata nel cartiglio. In definitiva, nella "ripetizione differente" di queste diverse sequenze formali, occorre vedere non soltanto l'"unità sistemica" dell'opera, ma anche la sua autonoma originalità espressiva rispetto all'"età cronologica" dei segnali provenienti dalle forme delle poetiche e dagli stili che si sono manifestati nel corso del tempo storico. Infatti l'estetologo Mario Perniola, Attraverso l'esame della teoria di George Kubler che ha sviluppato i concetti sull'estetica della forma del Focillon- ha dedotto che " nessuna opera d'arte esiste al di fuori delle continue sequenze" che collegano le cose alle espressioni e agli atti dell'uomo di tutti i tempi. E ricorda che "le cose stanno come gli angeli di Tommaso D' Aquino, in una dimensione intermedia tra l'eternità e il tempo: esse dimorano nell'aevum, cioè in una durata che ha inizio, ma non una fine!"("L'Estetica del novecento", il Mulino,1997). Sicchè la teorizzazione della "ripetizione differente di Cubler di diversità, nella continuità, sul presupposto innegabile che non è possibile che un artista compia "una operazione assolutamente identica ad un'altra".